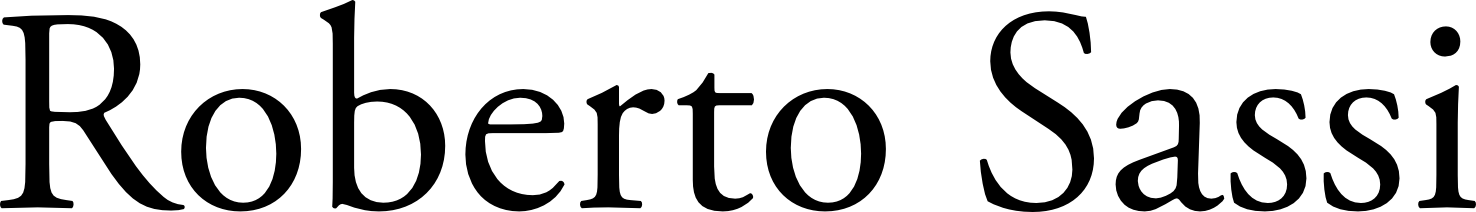«Dare un nome sbagliato alle cose – scriveva Albert Camus ne La peste – contribuisce all’infelicità del mondo». I nomi, quindi le parole, se non utilizzati col criterio della fedeltà alla vita, producono malinteso, rappresentano l’ingiustizia dello snaturamento, impediscono ogni forma di conoscenza genuina. Ma è poi davvero possibile praticare questo tipo di fedeltà attraverso le parole? Bisogna forse essere pronti a riconoscere il proprio luogo dell’ingiustizia, quello dove si genera il cortocircuito; bisogna forse essere pronti a riconoscere che il vero problema, il nodo da sciogliere, sono le idee, non le parole. Pensare secondo le idee significa coltivare il terreno del malinteso, accantonare ogni possibilità di coincidenza tra detto e vissuto.
Albert Camus è stato definito un filosofo per via della sua vocazione per la filosofia. È stato definito un esistenzialista per via del suo impegno a scavare nell’esistenza. Definizioni, l’una e l’altra, impregnate di idee e perciò irriverenti nei riguardi della vita vissuta, della complessità biografica. «Perché sono un artista e non un filosofo? Il fatto è che io penso secondo le parole e non secondo le idee», scriveva nei suoi Carnets, sconfessando una volta per tutte ogni altra impropria definizione. «No, non sono esistenzialista. Sartre ed io ci meravigliamo sempre di vedere i nostri nomi associati […] Sartre è esistenzialista, e il solo libro di idee che ho pubblicato, Le Mythe de Sisyphe, era diretto proprio contro le filosofie dette esistenzialiste», spiegava in un’intervista rilasciata nel 1945 al Magazine Littéraire. Ma le autodefinizioni evidentemente non sono sufficienti a fugare dubbi – o maliziose certezze – di critici affermati e semplici lettori; per molti Camus è stato e resta un filosofo esistenzialista. E poco importa se in verità è stato forse colui che, in tutta la sua opera, ha portato all’esistenzialismo l’attacco più sincero.
L’incapacità di raccontare – e quindi di capire – Camus senza far ricorso alla storia, alle posizioni politiche e alle categorie di pensiero proprie dell’esistenzialismo sartriano ha prodotto molti malintesi. E lo ha fatto in primo luogo nel corso della vita dello scrittore franco-algerino. Del resto, quando nel pensiero altrui si è legati a una particolare realtà sociale, politica o filosofica, ogni allontanamento è tradimento dei principi di quella realtà, è desiderio di distruggerla; e ogni spiegazione, più che onesto tentativo di chiarire le proprie posizioni, diventa maldestra manovra per smacchiarsi, per disinfettarsi dalla teoria e dalla pratica abiurate. L’oscillazione, la zigzagante ricerca di un posto nel mondo, di una giustificazione alla propria presenza, sono tradimento perché contraddicono il dogma laico di parte e di partito.
Nel 1935 Camus aderì al Partito Comunista Algerino. L’impegno a favore degli oppressi, di quelli che lui definiva les muets (i muti), il rifiuto di ogni atteggiamento accomodante rispetto al destino, le umili origini familiari lo avvicinarono in modo del tutto naturale al partito. Ma la sua militanza prese sin da subito una piega più culturale che politica in senso stretto. Al giovane studente di filosofia allievo di Jean Grenier non interessavano molto le speculazioni sulle grandi teorie economiche marxiste, né lo appassionava il successo industriale dell”Unione Sovietica stalinista. Si dedicava piuttosto al teatro, fondò una compagnia e mandò in scena Le Temps du mépris di Malraux. E chissà se per l’inatteso successo teatrale o per le posizioni filo-arabe (che in verità andavano, come poi chiarirà negli anni della guerra d’indipendenza, decisamente al di là del filo-arabismo) o per la propensione al corteggiamento («Quale tipo di donna mi piace? La più bella», rivelò una volta a un amico), fu precocemente espulso dal partito e accusato di aver abbracciato i principi borghesi, di essere diventato cioè uno “sporco fascista”. Falsità. Quel che mal si digeriva del giovane Camus era la predisposizione alla libertà di pensiero, alla libera analisi degli eventi, all’indisponibilità di piegare la morale alla strategia politica: vere minacce queste per la coscienza collettiva auspicata dalla rivoluzione comunista.
La sua biografia è piena di accuse di tradimento, spesso inasprite dalla complessità della sua riflessione sugli eventi storici più importanti. Nel 1953 prese posizione a favore della rivolta degli studenti e degli operai anticomunisti di Berlino, rivolta repressa nel sangue dai carri armati sovietici. Un altro argomento per coloro che lo vollero sempre traditore. E poco importa se i moti scoppiarono per protestare contro un taglio dello stipendio – atto che normalmente faceva gridare alla vergogna capitalistica –; il progetto di comunistizzazione del mondo prevedeva la possibilità di schierare i cannoni dei carri armati anche contro i propri fratelli. Nel 1956 Camus sostenne invece le ragioni dell’insurrezione di Budapest, definendo il governo filo-sovietico «un regime di terrore che ha il diritto di chiamarsi socialista come il boia dell’Inquisizione aveva il diritto di chiamarsi cristiano».
Ma furono le sue posizioni rispetto alla questione algerina a costargli più di tutte. Se Sartre e compagni si schierarono decisamente a favore dell’indipendenza araba, giustificando ogni mezzo per ottenerla, Camus, che era cresciuto a Belcourt, uno dei quartieri più poveri di Algeri, sostenne le ragioni della convivenza tra coloni francesi e popolazione araba, rigettando con forza ogni forma di cieca violenza. Secondo lui, coloro che erano nati negli stessi luoghi, che avevano patito la stessa fame e sofferto le stesse fatiche avevano diritto di calpestare quel suolo e dichiararsi algerini. Le sue ragioni rifiutarono ancora una volta di piegare la morale alla strategia, di ridurre la vita a un concerto di ideologie da applicare fideisticamente: «Ho sempre condannato il terrore. Devo condannare anche un terrorismo che si esercita ciecamente nelle strade di Algeri, e che può un giorno colpire mia madre o la mia famiglia. Io credo nella giustizia ma difenderò mia madre ancor prima della giustizia».
I violenti attacchi ricevuti lo condussero progressivamente al silenzio sulla questione algerina. La paura di essere frainteso, di essere considerato un nemico degli arabi, difensore di un colonialismo bieco e antiumanitario prevalse sul desiderio di spendersi per quella che forse è la causa più importante della sua vita. L’Algeria è in tutta la sua opera e gli eventi bellici gli provocarono una ferita che non riuscì mai a spiegare e che non si rimarginò. «Sono cresciuto nel mare e la povertà mi è stata fastosa, poi ho perduto il mare, tutti i lussi allora mi sono sembrati grigi, la miseria intollerabile. Da quel momento, attendo. Attendo le navi del ritorno, la casa delle acque, il giorno limpido», scrisse malinconicamente nel 1953 ne La mer au plus près. Non si rassegnò mai alla perdita dei luoghi della sua infanzia, della intensa luce algerina, della fraterna inimicizia degli arabi. «Pazientavo sempre nell”inverno perché sapevo che una notte, una sola notte fredda e pura di febbraio, i mandorli della valle dei Consoli si sarebbero coperti di fiori bianchi», raccontò nel 1940 ne Les Amandiers. Nessuna pazienza era possibile né necessaria senza l’Algeria.
Raccontare Camus senza raccontare la terra in cui è nato e cresciuto, senza tener conto del fatto che un’esistenza – e quindi un pensiero – sia sottoposta al cambiamento: può farlo soltanto chi finge di voler fare ordine, ma in verità desidera nascondere un certo naturale e inevitabile disordine. Ci sono molti modi per ricordare un intellettuale nel giorno del centenario della sua nascita. E uno di questi è interpretare il suo pensiero, riportarlo più o meno fedelmente, renderlo affascinante e in qualche modo coerente. Così, potrei accennare alla teoria dell’assurdo (non sono assurdi né il mondo né l’uomo; assurdo è l’incontro tra l’uomo e il mondo); potrei presentare il Meursault de L’Étranger, per cui tutto è talmente indifferente che non ricorda il giorno in cui è morta sua madre, che non versa una lacrima al suo funerale e anzi fa un bagno e va al cinema invece di rintanarsi nel lutto; il Meursault che spara a un arabo perché abbagliato dalla luce del sole; il Meursault per cui ogni difesa dalle accuse di omicidio non ha senso. Potrei dirvi di Jean-Baptiste Clamence, l’avvocato parigino che si rifugia ad Amsterdam e diventa giudice-penitente; il Jean-Baptiste Clamence che intrattiene con la verità un rapporto ambiguo («Che importa, dopo tutto, se le mie storie sono vere o false, se esse sono significative di ciò che io sono e sono stato?»). E ancora: la valenza metaforica e politica de La peste; la concezione della felicità del Mersault (senza una u) de La mort heureuse (la felicità come lunga pazienza, come costruzione e volontà).
Potrei parlare di tutto questo per raccontare Albert Camus, per rendergli un giusto omaggio. Ma che senso avrebbe, se non si abbandonano le idee a favore delle parole e non si è pronti a chiamare le cose col loro nome? Facendo appello esclusivamente alle idee, cos’è l’assurdo se non un concetto filosofico? Chi è Meursault, se non un assassino? E chi è Jean-Baptiste Clamence, se non un bugiardo?
Oggi, a cento anni dalla sua nascita, Albert Camus è osannato a destra per il suo anticomunismo, celebrato a sinistra per il suo impegno a favore degli oppressi. La grandezza della sua letteratura ha finito con l’appianare ogni divergenza di matrice politica. Si alza un coro unanime di apprezzamenti, qualcuno non può fare a meno di accostarlo a Sartre, qualcun altro lo mette nel pantheon della destra libertaria, altri ancora, credendo di essere alla fine degli anni Sessanta, lo ricordano per quel «Je me révolte, donc nous sommes» («Io mi rivolto, dunque noi siamo») che accese tanti cuori ribelli nell’epoca delle rivolte studentesche. Ma la grandezza della sua letteratura non ha soltanto smussato le asperità della discussione politica, ha finito anche col mettere in ombra l’importanza del pensiero che sta a fondamento dell’opera di Camus. Tanto che la sua lezione più grande, quella che invita a pensare secondo le parole e non secondo le idee, sembra che quasi nessuno l’abbia davvero capita.
Questo articolo è stato originariamente pubblicato su “Libernazione” il 7 novembre 2013